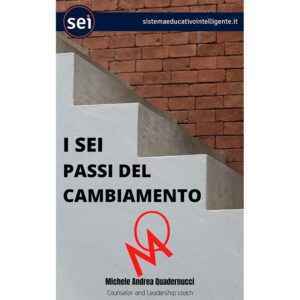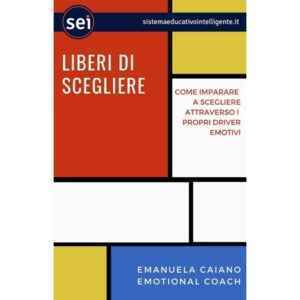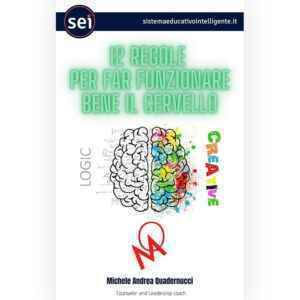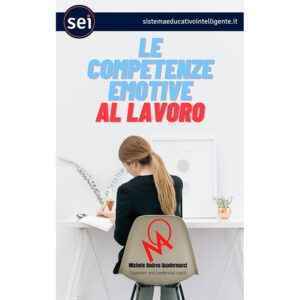Nessun prodotto nel carrello.

Perché dovremmo guardare “L'Isola delle Rose”, film presente in questi giorni sulla piattaforma Netflix?
Perché dovremmo guardare “L’Isola delle Rose”, film presente in questi giorni sulla piattaforma Netflix?
Vi elenco qualche buon motivo.
Innanzitutto è una storia vera. E che storia!

Ambientata negli anni 60, nel fior fiore del boom economico, dove tutto o quasi era possibile, l’Ing. Giorgio Rosa, da poco abilitato alla professione di ingegnere, ha pensato bene di costruirsi uno Stato tutto da solo a poche miglia dalla costa italiana.
Avete capito bene: uno Stato, con il suo governo, la sua lingua (l’esperanto), i suoi francobolli e addirittura la moneta il Mills (in realtà mai battuta).
Ripercorriamo alcuni fatti storici
Il giovane ingegnere fondò la Repubblica Esperantista dell’Isola delle Rose, una superficie di circa 400 metri quadrati ricavata su una piattaforma artificiale da lui costruita (e brevettata), ancorandola a quasi 12 km da Rimini, 500 metri oltre le acque territoriali italiane.
Assomigliava ad una piattaforma petrolifera, ma in realtà da quell’isola non si ricavava il petrolio, ma un bene ancora più prezioso, la libertà.
La curiosità ha spinto molti a raggiungerla, approfittando del periodo estivo e del bar e del ristorante in piena attività sull’isola.
L’Italia stava vivendo in pieno il periodo delle rivoluzioni sociali, la prorompente crescita economica, l’incessante desiderio di indipendenza e disconoscenza della classe politica di quegli anni.
Inizialmente l’idea dell’Isola delle rose era nata per un interesse commerciale: il turismo in Romagna stava crescendo, un’isola in mezzo al mare poteva rappresentare un’ottima attrattiva.

Poi una burocrazia ostile ad ogni atto creativo, porta l’Ingegner Rosa già con una natura eccentrica, alla realizzazione di uno Stato con il suo governo e le sue regole.
Un’iniziativa che certo non piacque ai politici e allo Stato Italiano. Il Governo si preoccupa infatti dei proventi turistici che l’ingegnere stava raccogliendo senza pagare nessun tipo di tassa.
Nessuna Nazione del mondo riconobbe lo status dell’Isola delle Rose che, però, nel frattempo si diede un governo. A presiederlo c’era Giorgio Rosa, nel ruolo di presidente del Consiglio dei Dipartimenti, coadiuvato da uffici relativi alle Finanze, agli Affari Interni, all’Industria, al Commercio e agli Affari Esteri. Ricoprirono le cariche amici e parenti, come medici o commercialisti.
Tutta gente “normale”, per usare un termine di Giorgio Rosa.
La reazione dello Stato Italiano è stata dura: inizialmente ha provato a convincere l’ideatore a desistere con offerte di concessioni sulla terraferma; poi, di fronte alla sua ostinazione, ha organizzato un vero e proprio attacco navale, che ha portato alla distruzione dell’isola.
Cosa ci insegna l’incredibile vicenda dell’Isola delle Rose
È un racconto di libertà, il desiderio di realizzare un’utopia in un’epoca in cui, l’individualismo prevale su un senso di omologazione.
Non è stata un’impresa ideologia, è stata l’utopia di poter fare una cosa da soli, molto grande.
Certo è finita male, ma l’utopia, in senso sociologico, ha una forza motrice così ampia che appaga ogni sogno intrinseco di un uomo.

Concluderei con il pensiero di Mannheim, dal suo saggio “Ideologia e utopia”, che dà una descrizione calzante alle dinamiche che innescano un pensiero utopistico.
“Esistono dei gruppi subordinati, così fortemente impegnati nella distribuzione e nella trasformazione di una determinata condizione sociale, da non riuscire a scorgere nella realtà se non quegli elementi che essi tendono a negare.
Il loro pensiero è incapace di una diagnosi corretta della società presente.
Tali gruppi non si occupano affatto di ciò che realmente esiste, bensì cercano con ogni mezzo di mutarlo. Il loro pensiero non è mai un quadro obbiettivo della situazione, ma può essere usato soltanto come una direzione per l’azione.
Nella mentalità utopica, l’inconscio collettivo, mosso essenzialmente dai progetti per il futuro e da una decisa volontà pragmatica, finisce con il trascurare alcuni aspetti della realtà”
ARTICOLI SUGGERITI
I 6 passi del cambiamento
[Parole: 2335]
Questo ebook è un protocollo di lavoro da usare su se stessi per cambiare tutti i comportamenti ...
Liberi di scegliere
[Parole: 3417]
In questa mini-guida conoscerai quali sono i tuoi driver emotivi, ossia le tue leve motivazional...
12 Regole del cervello
[Parole: 1973]
Questo e-book ti permetterà di comprendere le 12 regole basilari per far funzionare bene il tuo ...